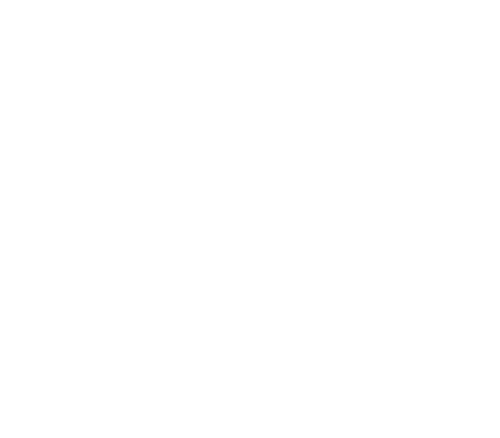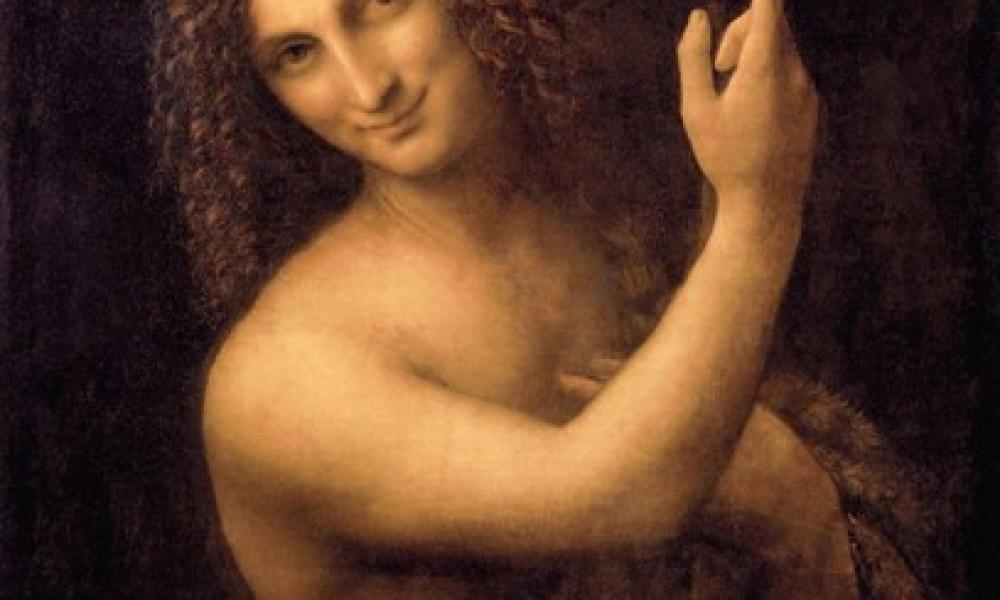Le feste di San Giovanni Battista, il 24 Giugno, e dell’Apostolo Giovanni, il 27 Dicembre, sono strettamente connesse ai solstizi. La prima cade in prossimità del solstizio estivo, nel periodo in cui il sole comincia a decrescere e le ore di luce iniziano a diminuire, mentre la seconda, in concomitanza col solstizio invernale, segna il confine tra l’anno vecchio che si conclude ed quello nuovo che si apre. Per tradizione, questi due giorni sono considerati “porte” solstiziali ed interpretati come momenti di passaggio tra diverse stagioni, regolati e custoditi dalla divinità romana di Giano, il dio bifronte che apre e chiude le porte dei cicli naturali e umani ma che protegge anche tutti i passaggi pubblici e privati, delle città e delle abitazioni. L’etimologia del nome Giano rivela esattamente questa funzione: janus deriva dalla radice indo‐europea y‐ã, “passaggio”, da cui il sanscrito yana, “via”, e il latino ianua, “porta”. Durante il Medioevo la somiglianza fonetica tra Janus e Johannes ha ispirato lo sdoppiamento della figura del dio romano in quella dei due santi cristiani, teoria suggestiva ma priva di alcun fondamento etimologico. “Accanto a questa ipotesi vi è quella più concreta basata sull’etimologia ebraica della parola Jehôhãnãn, composta da Jahweh, Dio, e hãnãn, misericordia oppure lode” (Lazzarini; 1993).
La festa cristiana di San Giovanni Battista si sovrappone a quella che celebra il solstizio d’estate, ma non è mai riuscita a sostituirsi efficacemente alla natura pagana della celebrazione. Ancora oggi infatti, nella notte del 23 Giugno, alla vigilia, sacro e profano convivono in un’unica dimensione; in moltissime località di tutta Italia si accendono grandi falò che accompagnano il sole nella sua decrescita (i Fuochi di San Giovanni), si effettuano dei pronostici amorosi e si coltiva la credenza delle proprietà benefiche e purificatrici della rugiada e delle erbe che essa bagna durante questa magica notte di trapasso. “Un catino colmo d’acqua, di fiori, di spighe di lavanda e di erbe odorose lasciato per tutta la notte all’esposizione astrale e ritirato prima del primo raggio del sole del mattino contiene acqua fiorita di virtù taumaturgiche e capace di mantenere giovane e bella la persona che l’usa per lavarsi il volto al sorgere del sole” (ibidem).

Era credenza diffusa che le piante raccolte nella notte dei prodigi potessero curare malattie e dolori, come testimonia l’usanza abruzzese di cingere la vita con i rami fioriti di vitalba per preservare la persona dal male di stomaco e di ventre. A Montevergine (Sulmona), durante la notte di San Giovanni “Le persone di ogni sesso ed età (…) intrecciano corone di rose e di altri fiori, o cingono alla vita serti di vitalba (vitàcchia). Levato il sole, si torna indietro con le corone e con le vitalbe, le quali sono conservate, come cosa sacra, per applicarle nei casi di dolor di capo o di ventre” (Finamore; 1890). Ugualmente accadeva a Pettorano dove “Le donne che, al mattino, nel dì di s. Giovanni, vanno ad attingere l’acqua, fanno corone di vitàcchia, e ne ornano le conche” (ibidem). Gabriele D’Annunzio, in “Le Novelle della Pescara” (1902), fa accenno all’uso di cingersi la testa con la vitalba fiorita. La vitalba (Clematis vitalba), pianta lianosa dai rami molto flessibili, era particolarmente considerata per le sue qualità soprannaturali. “Nel Teramano, nel secolo scorso era ancora in uso l’imprecazione “Chi sci ‘mbise che le veticchie cume Cicche d’Ascule” ossia “Che tu possa essere impiccato con la vitalba come Cecco d’Ascoli” (Manzi; 2003). Giuseppe Savini (1881) fornisce la spiegazione di questa minaccia piuttosto insolita. “Il popolo narra che menato Cecco d’Ascoli ad impiccare, a qualunque corda veniva impeso, tutte si rompevano, perché quegli era quel maliardo che sapete. Infine i ministri della giustizia non sapevano a che corda votarsi, quando si udì per l’aria una voce gridare: Veticchie, veticchie! Era il diavolo che insegnava quell’unico modo di vincere le fattucchierie di Cecco d’Ascoli. Fatto subito tesoro di quel suggerimento, ed impeso coi viticchi, Cecco restò morto” (ibidem).
A fronte di tutte le credenze sulla sacralità delle piante e dei fiori di San Giovanni, la Chiesa dovette condannare aspramente molte delle usanze superstiziose che già nel XVII° secolo risultano ampiamente diffuse. Nelle “Decisiones Prudentiales” troviamo le ammonizioni a “Le donne che nel giorno di S. Gio. Battista colgono i fiori de herba avanti che si levi il sole, e le fanno benedire da sacerdoti per farne Agnus Dei, o come esse dicono, vangelii, et portarli addosso”, dove con Agnus Dei si intendono quelle “medaglie o piccole cere impresse con un’immagine sacra da portare addosso, come amuleti, dette agnusdei perché di solito quell’immagine è l’agnello, simbolo del Cristo” (Crocioni; 1947).
Oltre a queste usanze appena accennate ne esisteva una che è giusto approfondire un po’ meglio e che sempre utilizza le piante e i fiori come leganti tra due individui. In questo caso la tradizione crea un legame di parentela spirituale tra due persone (i “compari” gli individui di sesso maschile e le “comari” quelli di sesso femminile) attraverso un rito simbolico. Questa consuetudine prende il nome di Comparatico di San Giovanni e le persone che si trovavano a stringere il patto si potevano considerare Compari oppure Comari di San Giovanni. La caratteristica principale è che questo accordo fosse considerato sacro e indissolubile. “S. Giovanni, consacrando i mutui affetti, li purifica, li esalta, ne fa delle parentele spirituali. Nella mente del popolo, questo del s. Giovanni è il comparatico per eccellenza, ond’è che, nel nostro uso, s. Giovanni è sinonimo di Compare e di Comparatico; e la violazione di siffatto legame, santo non meno di quello stabilito coi sacramenti del battesimo, della cresima e del matrimonio, è ritenuta più che mai sacrilega e meritevole di terribili castighi” (Finamore; 1890).Un testimone di Isola san Biagio (Montemonaco), racconta come “In campagna, il giorno di San Giovanni, i contadini si facevano compari e comari. Il più giovane faceva un regalo al più anziano: una cinghia, un cappello, un fazzoletto per il collo. Il giorno di San Pietro l’altro rifaceva il regalo, il capezzale si chiamava. Era una specie d’unione, un vincolo di sostegno reciproco, di solidarietà assoluta, più che una parentela: diventavano fratelli e sorelle (…)” (Polia; 2012). Il legame ottenuto, di valore intrinsecamente più elevato di quello acquisito dai comparatici religiosi attraverso il battesimo e il matrimonio, aveva come finalità la fortificazione non solo di un’amicizia leale ed eterna, ma anche un mutuo sostegno negli aspetti quotidiani della vita e del lavoro. Ad esempio, il comparatico poteva essere contratto tra due contadini che condividevano un confine tra i propri terreni con l’obiettivo di non prevaricare mai l’uno sull’altro. “A Polverina di Comunanza ci si faceva a comare e compare perché così con quella persona “non ce se ‘rregnava”: si era sicuri infatti di creare un legame stabile e duraturo, in quanto era praticamente vietato litigare con questi veri e propri parenti acquisiti, altrimenti si attiravano sulla propria persona disgrazie e sofferenze, non avendo rispettato un patto sancito solo oralmente e privatamente ma considerato ugualmente indissolubile” (Piccioni; 2014). Le fasi per cui si diventava compari di San Giovanni si sviluppavano nell’arco delle giornate che vanno dal 24 al 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, in cui solitamente si doveva rispondere al compare o alla comare contraccambiando il dono ricevuto. Presso Astorara e Colleluce (Montegallo), “Tra donne, si regalava un vestito, un fazzoletto ricamato e sempre un mazzo di fiori e si diceva all’amica del cuore:
Il mazzo è piccolino, la fest’è ‘ranne,
t’accette pe cummare de San Giuanne.
Il giorno di San Pietro, invece:
Il mazzo è piccolino, la fest’è arrète,
t’accette pe’ cummare de San Pietre” (Polia; 2012).

“Materia del rito sono i fiori, che, per sé stessi, in quel giorno, sono qualcosa di sacro; e l’ordinario è che il mazzolino (ramajjétte), mandato nel dì di san Giovanni, sia ricambiato in quello di s. Pietro. Ma non manca il caso che i mazzi – ji mazze – si ricambino nello stesso giorno” (Finamore; 1890).
Il vincolo di amicizia e di solidarietà legava i contraenti per la vita e per la morte. “Si parlava infatti di un “giuramento di san Giovanni”, che finiva coll’unire centinaia di persone che tra loro neppure si conoscevano, poiché chi diventava comare o compare di qualcuno, a sua volta mandava il mazzo di fiori (si diceva infatti “comare o compare di mazzo”) ad altra persona” (Balena; 1984). Secondo l’autore, quindi, il comparatico avveniva da principio tra due persone e, per proprietà transitiva, si allargava a tutti coloro che venivano conseguentemente legati da un altro patto ad uno di questi due individui della matrice iniziale. “Si creava così una vera e propria catena che restava a metà strada tra la confraternita e la società segreta. (…) In ogni caso vale la pena ricordare che il giuramento a san Giovanni era ugualmente valido (e spesso veniva ripetuto in segno di accettazione) se fatto cinque giorni dopo, nella festa di san Pietro e san Paolo. Proprio da questo lontano rito era nata la setta segreta siciliana dei “beati Paoli” che, secondo taluni, proponendosi di amministrare una specie di giustizia popolare, viene posta all’origine della mafia”. Seppure intrigante, la teoria proposta dallo studioso ascolano non trova riscontro né nelle indagini antropologiche di Pitrè (“Il comparatico” e “La mafia e l’omertà”, in “Usi e costumi”, 1889 ) né in altra documentazione, ed effettivamente ancora oggi le origini e le caratteristiche della presunta setta non sono affatto chiare.
L’unica ipotesi che possiamo fornire su questo collegamento spontaneo di Balena sono le parole dell’antropologo siciliano che scriveva: “Posto che S. Giovanni è il più grande de’ santi, che è vindice del comparatico, che un’offesa fatta a questo è un’offesa fatta direttamente a lui, che in lui si contraggono i legami più saldi e più sacri del mondo, è agevole il supporre quale influenza eserciti egli nel basso popolo, e quali miracoli debba operare. Tra persone temibili per indole rissosa e vendicativa, tra gente alla quale siano norme di condotta i principi della così detta mafia, il comparatico è un gran bene e un gran male: un gran bene per essa, un gran male, non disgiunto talvolta anche da un po’ di bene, per la società” (Pitrè; 1889).
Anche se a stringere il patto erano soprattutto ragazze, gli scambi di doni avvenivano anche tra innamorati.
“Gli amanti usano regalarsi di castagne e porto galli nel giorno di S. Tomasso; di confetti nel Carnevale; di mazzi di fiori e confetti, di scialletti, di cappelli di paglia, adorni di fettucce e fiori tinti, nel giorno di S, Giovanni all’epoca della mietitura” (Spadoni; 1966). Si regalavano mazzetti di fiori e fazzoletti ricamati, spesso con le iniziali del donatore o con frasi romantiche, come quello che descrive accuratamente Alfiero Romualdi tracciando il ritratto di una sua anziana zia “la più vecchia – nata nel 1850 e morta nel 1944 – che si annoverasse a Fioli fin verso metà secolo; (…) ancorché ultranovantenne, portava in testa un fazzoletto bianco di lana, probabilmente tessuto a mano e liso per lungo uso, con questi speculari versetti ricamati a punto croce con filo rosso su due bordi di un angolo (versetti relativi evidentemente alla prima giovinezza, sua e/o di altre):
Mi ricordo quando mi dicesti:
Era tuo il cuor che mi rubasti” (Romualdi; 2005).

Lo scambio dei fiori nei comparatici di san Giovanni era diffuso in ogni parte dell’Italia centrale e meridionale e proprio per questo aspetto spesso i contraenti prendevano il nome di “compari di fiori” o, come a Fabriano, “comari del mazzolino” (Crocioni; 1951). “In Valnerina, le donne che nel giorno di San Giovanni avevano stretto il vincolo del comparatico, erano dette “commari a mazzettu”, dallo scambio del mazzolino di fiori raccolti nella notte della vigilia mediante il quale suggellavano il patto. Oltre ai fiori, le donne usavano scambiarsi mutuamente un fazzoletto da testa ricamato per l’occasione, cerimonia detta “scambia’ li panni”. Gli uomini, nel giorno di San Giovanni, usavano scambiarsi dei cappelli, fazzoletti da collo o le cinghie per le brache; il giorno di San Pietro, il dono doveva essere ricambiato e, a indicare il valore vincolante di tale pegno, il dono era detto “lu capezzale”” (Polia; 2009). A Pesaro l’aglio si ritrova strettamente legato a questa tradizione tanto che “i giovinotti li comprano insieme ai fiori, quest’ultimi simboleggianti l’affetto e l’amore” (Mannocchi; 1921). L’uso degli spicchi d’aglio come amuleti contro la fascinazione e l’invidia era un’usanza assai diffusa anche nei paesi del Piceno, seppur non così strettamente collegata alla festa di San Giovanni Battista e alla legatura del comparatico.
Sempre nelle “Decisiones Prudentiales” seicentesche, leggiamo il monito a “Quelli che nella vigilia di S. Gio. Battista fanno fuochi, passando sopra di quelli, toccandosi per la mano, poi si chiamano compadri e comadri di S. Giovanni” (Crocioni; 1947). Era evidentemente un altro modo di contrarre il patto in tempi più remoti e che univa i due elementi pagani, entrambi rimasti saldamente ancorati alla festività sacra.Nel vicino Abruzzo sono documentati altri modi per stringere il comparatico, come a Palena dove “due giovanetti o giovanette, scambiatisi prima i fiori, e legatisi coi diti mignoli, girano così tre volte intorno all’altare maggiore della chiesa in cui si celebra la festa, recitando:
Cummar’ e ccumbare, nghe ssan Giuvanne care,
la féda che tt’attocche
nne’ la huasta’, ca vjìe a la morte. Catenèlla, catenèlle,
nne’ la huasta’ ca vjìe a le ‘mbèrne” (Finamore; 1890)
Questo rito può essere facilmente comparato con alcuni usi nuziali in voga presso alcune culture straniere, come in India dove anticamente lo sposo prendeva per mano la sposa e le faceva fare tre giri di altare dicendo: “Vieni, sposiamoci, facciamo figli. Uniti d’amor, gloriosi, contenti, viviamo cento anni”. Il movimento circolare ripetuto tre volte simboleggia il viaggio della vita, da percorrere insieme. Allo stesso modo gli sposi romani compivano tre giri intorno all’altare mentre una terza persona posta davanti alla sposa portava il farro come augurio di fecondità. Nelle nozze russe i due sposi tengono in una mano una candela e, tenendosi con l’altra mano, fanno tre giri intorno all’altare e si scambiano un bacio (De Gubernatis; 1869).
Bibliografia
Balena S., “Folklore Piceno”, Edizioni Turistiche, Ascoli Piceno, 1984
Crocioni G., “Superstizioni e pregiudizi nelle Marche durante il Seicento”, Edizioni Ripostes, Salerno, 2001 (ristampa del 1947)
Crocioni G., “La gente marchigiana nelle sue tradizioni”, Edizioni Corticelli, Milano, 1951
De Gubernatis A., “Storia comparata degli usi nuziali in Italia e presso gli altri popoli indo‐europei”, E. Treves & C. Editori, Milano, 1869
Finamore G., “Credenze usi e costumi abruzzesi”, Adelmo Polla Editore, Palermo, 2002 (ristampa del 1890)
Lazzarini E., “La notte di San Giovanni. Erbe e magia”, Aiep Editore, Repubblica di San Marino, 1993
Mannocchi L., “Feste, costumanze, superstizioni popolari nel circondario di Fermo”, Tipografia Economica, Fermo, 1921
Manzi A., “Piante sacre e magiche in Abruzzo”, Casa Editrice Rocco Carabba, Lanciano, 2003) Piccioni G., “Alla ricerca delle tradizioni perdute …”, BIM Tronto, Ascoli Piceno, 2014
Pitrè G., “Usi e costumi. Credenze e pregiudizi del popolo siciliano” vol. II, Palermo, 1889
Polia M., “Tra cielo e terra. Religione e magia nel mondo rurale della Valnerina” vol. I, Edicit, Foligno, 2009
Polia M., “L’aratro e la barca. Tradizioni picene nella memoria dei superstiti” vol. I, Lìbrati, Ascoli Piceno, 2012
Romualdi A., “Il XX secolo ai piedi della Laga”, Montorfano, 2005
Spadoni D., “Alcune costumanze e curiosità storiche marchigiane”, Arnaldo Forni Editore, Bologna, 1966
Savini G., “La grammatica ed il lessico del dialetto Teramano”, Torino, 1881