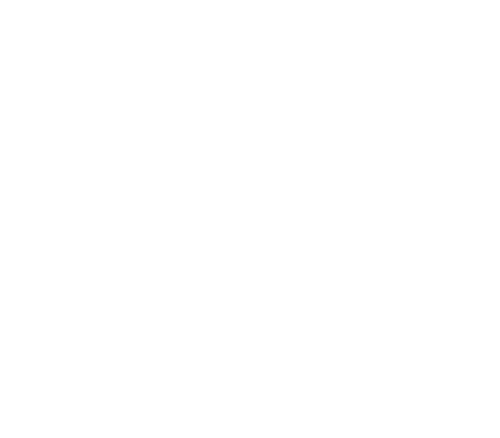Pochi riescono a confrontarsi con una sfida ardua come quella di riprodurre la natura in ogni minimo dettaglio. Eppure, Albrecht Dürer (1471-1528), uno dei più grandi artisti della Wiedererwachung tedesca, la superò con maestria, dando prova di amorevole pazienza e creando opere che ancora oggi ci sorprendono per il loro realismo e la straordinaria precisione. Dalla sua aveva una tecnica grafica invidiabile ereditata dal padre orafo e dei sensi affinati su cui si poggiò la sua ricerca empirica, che sfociò in ritratti così vividi e particolareggiati da far apparire quasi vivi i soggetti raffigurati. I suoi studi sugli animali, in particolare, eseguiti con una combinazione di disegno, acquerello e guazzo, sono tra le testimonianze più straordinarie di come il produrre arte per quegli artisti-artigiani del Rinascimento non poteva sussistere senza l’osservazione scientifica della realtà e senza un certo fascino per i più fini particolari.
Non fu l’unico, certo, ma l’atteggiamento di Dürer, così come quello di Leonardo, era diverso: scientifico. L’arte per lui era soprattutto un mezzo per indagare e studiare la natura in quanto sistema complesso e strutturato da regole precise, e per definirne la realtà visiva: la raffigurazione doveva essere rigorosa, basata prima di tutto sulla diretta osservazione, innalzando così il valore conoscitivo di un mezzo visivo come l’arte. L’animale non era più un semplice motivo pittorico di cui potersi servire in altre opere di più grande formato, dunque, ma un vero enigma con cui misurarsi: quello della natura tangibile, con i suoi pregi e i suoi difetti, che in fin dei conti sono difetti solo ai nostri occhi pieni di ideali. Così scriveva il pittore: «La natura contiene il bello, per l'artista che ha l'intuizione di estrarlo. Così, la bellezza si trova anche nelle cose umili, forse brutte, e l'ideale, che aggira o migliora la natura, alla fine potrebbe non essere veramente bello».
La Lepre (1502), custodita all’Albertina di Vienna, è forse il più popolare dei suoi studi sugli animali. Esso ritrae una lepre accovacciata ma con le orecchie vigili, segno che forse Dürer ritrasse un esemplare vivo. Sono l’attenzione che l’artista ripone sul pelo dell’animale, il modo in cui il colore bianco della luce ne disegna il volume, la variazione dei toni cromatici che costruiscono la trama della pelliccia e il riflesso di una finestra sull’occhio della lepre a conferire al soggetto una vitalità eccezionale.
Parte della stessa collezione, la Piccola civetta costituisce il ponte tra un mondo folklorico e superstizioso e un realismo privo delle ombre del cattivo auspicio simboleggiato da questo rapace, nei cui occhi si rispecchiano le finestre dello studio di un artista-scienziato, la cui curiosità e diligenza segnarono una svolta nella storia dell’illustrazione scientifica. Questo dimostrano, analogamente, anche la Testa di Capriolo, in cui si può notare la precisione nella raffigurazione della rosa e delle protuberanze delle perle dei palchi dell’esemplare, così come la loro resa materica, e i Due scoiattoli. I due roditori, in particolare, esibiscono una pelliccia dalle ricche sfumature rosso ruggine con i dettagli così intricati ed elaborati da renderne la consistenza morbida. Quello in primo piano è intento a rosicchiare ciò che tiene tra le zampe, e i frammenti che cadono, così come le noci e i gusci a terra, o il modo in cui le zampe sono accartocciate in tensione, rendono il naturalismo dell’immagine ancora più pregnante.
L’osservazione non avveniva solo su animali vivi, ma anche su esemplari morti, come dimostra l’Ala di ghiandaia marina, in cui l’artista mette in mostra un aspetto raramente osservabile, ovvero la parte inferiore dell’ala e le sfumature dei suoi colori. Sebbene forse, come per altri disegni, si trattasse di uno studio, la finitura, la qualità e la raffinatezza dei dettagli delle piume, delle penne e dei colori dell’esemplare lo rendono un pezzo finito, un’opera a sé. Altri esempi degni di menzione sono: il Granchio marino, ritratto con un’attenzione meticolosa per il suo esoscheletro; il Pipistrello, raffigurato con le ali aperte, che si distingue per la sua precisione anatomica; il Cervo volante, probabilmente la prima raffigurazione affidabile di questa specie in ambito europeo.
Tanto ardenti erano la curiosità e l’entusiasmo che spingevano Dürer ad indagare e studiare anche le specie a cui non aveva facile accesso, che, ironia della sorte, furono proprio queste a causarne morte. Fu infatti probabilmente durante un viaggio verso i Paesi Bassi nel 1520, intrapreso con la speranza di vedere una balena arenata, che l’artista tedesco contrasse la malaria. In quella stessa occasione, ebbe l'opportunità di osservare anche un tricheco, che successivamente ritrasse solo affidandosi alla propria memoria. Per questo motivo la resa non risulta anatomicamente fedele e ha un aspetto strano, quasi comico. Il suo interesse per la natura, però, non si risolveva al mondo animale. Esso si estendeva anche ad altri aspetti della realtà, e, in particolare, alla flora.
Uno dei suoi più famosi studi naturalistici, La grande zolla, raffigura un microcosmo di piante selvatiche libere dalla simbologia che le contraddistingue sempre in quadri e affreschi; un gruppo apparentemente disordinato volto però a trasmettere una pacifica armonia di movimenti. Assieme ad altri studi come Otto studi di fiori selvatici, o Studio di un giglio (ma la lista è lunga) Dürer ha elevato la riproduzione artistica della natura a strumento di indagine scientifica e di conoscenza, riuscendo a catturare l’essenza della realtà naturale con una precisione tipica della squisitezza dell’arte nordica. Sono opere delicate e preziose che continuano ad incantarci, suscitando il nostro stupore; istantanee indelebili catturate solo da un occhio umano incredibilmente attento e indubbiamente capace di cogliere quei dettagli che sfuggono ai più, restituendoci la natura nella sua forma più autentica e affascinante, priva di infruttuosi idealismi.